
“Da quando sono uscita dal carcere la vita è stata difficile, solo adesso comincia ad andare bene. Volevano mandarmi via dall’Italia, sono finita nel CPR di Ponte Galeria perché giudicata un pericolo sociale. Nella mia vita ho avuto tanti problemi, ho passato un inferno, è stato tanto difficile”. Karima, nome di fantasia per proteggerne la vera identità, parla della sua vita e di tutto quello che ha dovuto affrontare, in fuga dalla Nigeria alla Libia fino all’Italia. Questa è una storia di coraggio.
La fuga dalla Nigeria
“Sono nata in Nigeria in un piccolo villaggio, dove sono cresciuta con i miei genitori e tre fratelli e tre sorelle. La mia era una famiglia molto allegra e numerosa: zii, cognati, nipoti e cugini vivevamo tutti assieme, sotto lo stesso tetto. Della mia vita non posso parlare di alcune cose, non riesco ancora a superarle, ho tanta difficoltà nel raccontarle. Posso solo dire che, quando ero piccola, ho subito una brutta aggressione. Sono stata torturata e sottoposta a molte molestie. Vorrei riuscire a raccontare cosa mi è successo, ma proprio non ci riesco. In seguito a questi problemi sono dovuta scappare, quando ci sono riuscita avevo 23 anni. Ho lasciato la Nigeria con mio marito. Lui conosceva delle persone che gli avevano consigliato di andare in Libia, dove poteva trovare facilmente lavoro come muratore. Io avevo tanta voglia di lasciare il mio Paese e scappare lontano. Quando abbiamo deciso di partire non avevamo soldi, quindi i mei genitori ci hanno prestato il denaro per i primi tempi. Siamo arrivati in Libia attraversando il deserto. Ben presto, però, abbiamo capito che la situazione non era quella che ci era stata raccontata. Così, nel 2011, attraversando il mare siamo arrivati in Italia a Lampedusa, dove siamo stati in un campo per rifugiati. 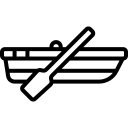 Per un po’ di tempo lo Stato italiano ci ha dato una mano, ospitati in una casa accoglienza a Trieste come richiedenti asilo politico. Ma, ricevuti i documenti, ci hanno detto che dovevamo andar via. Allora abbiamo preso una camera in affitto con i pochi soldi a nostra disposizione. Finiti quelli abbiamo deciso di andare a vivere a Napoli, dove è successo il disastro”.
Per un po’ di tempo lo Stato italiano ci ha dato una mano, ospitati in una casa accoglienza a Trieste come richiedenti asilo politico. Ma, ricevuti i documenti, ci hanno detto che dovevamo andar via. Allora abbiamo preso una camera in affitto con i pochi soldi a nostra disposizione. Finiti quelli abbiamo deciso di andare a vivere a Napoli, dove è successo il disastro”.
L’errore commesso a Napoli
“Quando io e mio marito siamo andati a Napoli inizialmente andava abbastanza bene. Io lavoravo come cameriera. Era un lavoro in nero che mi faceva guadagnare pochi soldi, però ero molto felice di poter lavorare. Ma dopo che il ristorante è stato chiuso per fallimento, la situazione è andata sempre peggio. Ero molto triste, mi sentivo sola e lontana dalla mia famiglia. Poi, un giorno, ho conosciuto una signora che parlava il mio stesso dialetto. Non potevo crederci, ricordo di aver pensato: “Wow, eccola! Finalmente ho incontrato una persona che parla la mia lingua”. Ci siamo scambiate i numeri di telefono, mi ha invitato anche a casa sua. Era molto gentile e presto siamo diventate molto amiche. In quel periodo, quando avevo una difficoltà, lei c’era sempre. Mi prestava i soldi se non riuscivo a pagare l’affitto e mi dava una mano in caso di necessità. Solo dopo, pian piano, ha cominciato a propormi di fare un viaggio in Africa. Mi diceva che così avrei potuto guadagnare facilmente, che io e mio marito avremmo finalmente risolto i nostri problemi e pagato tutti i nostri debiti. Ci siamo lasciati convincere. Io e mio marito siamo andati in Uganda e, al nostro rientro in Italia, siamo stati arrestati in aeroporto. 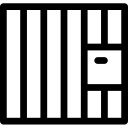 Trasportavamo droga. Sono stata separata da mio marito e sono stata condotta al carcere di Civitavecchia, dove mi hanno condannata a quattro anni di reclusione. Con la buona condotta la pena è stata poi ridotta a tre anni e quattro mesi”.
Trasportavamo droga. Sono stata separata da mio marito e sono stata condotta al carcere di Civitavecchia, dove mi hanno condannata a quattro anni di reclusione. Con la buona condotta la pena è stata poi ridotta a tre anni e quattro mesi”.
La vita in carcere
“La vita in carcere non è facile. È molto dura soprattutto all’inizio, quando non capisci ancora bene cosa ti stia accadendo. Infatti, mi ci è voluto un po’ di tempo per comprendere fino in fondo la mia situazione. Quando sono stata arrestata non conoscevo la gravità del reato che avevo commesso, ma questo non giustifica il mio errore. In carcere alla libertà e alla famiglia pensavo continuamente, così come pensavo a mio marito, anche lui in prigione, e a tutto quello che avevo perduto. 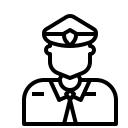 Noi immigrati, in un certo senso, siamo abituati a vivere lontani dalle nostre famiglie e dai nostri affetti. Ma io, almeno telefonicamente, ero rimasta sempre in contatto con i miei parenti e non ero affatto preparata a non parlarci più. In tre anni e quattro mesi di detenzione sono riuscita a telefonare alla mia famiglia solo una volta. Ero molto sola, non c’era nessuno che potesse venire a farmi visita e nessuno mi scriveva. Ricordo che a quel tempo avrei tanto voluto ricevere una lettera, non importava da chi, anche da uno sconosciuto. Ma quello che mi ha fatto stare più male, quello che mi logorava dentro era come io avessi potuto fare ciò che avevo fatto. Intanto i giorni passavano e, dopo lo sconforto iniziale, pian piano ho cominciato ad aprirmi. Sono andata a scuola, ho preso la licenza media, ho iniziato a lavorare come cuoca e a seguire dei corsi, come quello di italiano. In fondo in carcere ho guadagnato molto dai miei errori! Ma è stato difficilissimo, bisogna accettare di essere rinchiusi e di non poter uscire. Solo allora si può cercare di utilizzare il tempo nel migliore dei modi, rendendosi utili per gli altri e anche per sé stessi”.
Noi immigrati, in un certo senso, siamo abituati a vivere lontani dalle nostre famiglie e dai nostri affetti. Ma io, almeno telefonicamente, ero rimasta sempre in contatto con i miei parenti e non ero affatto preparata a non parlarci più. In tre anni e quattro mesi di detenzione sono riuscita a telefonare alla mia famiglia solo una volta. Ero molto sola, non c’era nessuno che potesse venire a farmi visita e nessuno mi scriveva. Ricordo che a quel tempo avrei tanto voluto ricevere una lettera, non importava da chi, anche da uno sconosciuto. Ma quello che mi ha fatto stare più male, quello che mi logorava dentro era come io avessi potuto fare ciò che avevo fatto. Intanto i giorni passavano e, dopo lo sconforto iniziale, pian piano ho cominciato ad aprirmi. Sono andata a scuola, ho preso la licenza media, ho iniziato a lavorare come cuoca e a seguire dei corsi, come quello di italiano. In fondo in carcere ho guadagnato molto dai miei errori! Ma è stato difficilissimo, bisogna accettare di essere rinchiusi e di non poter uscire. Solo allora si può cercare di utilizzare il tempo nel migliore dei modi, rendendosi utili per gli altri e anche per sé stessi”.
Isolamento
“Dividevo la cella solo con un’altra donna, perché il carcere femminile di Civitavecchia è piccolissimo, ospita una trentina di detenute al massimo. Non c’era tempo di stringere amicizie. Le detenute arrivavano e andavano via di continuo. Credo che in quel periodo io fossi la carcerata più anziana, nel senso quella che viveva lì da più tempo. Quando sei dentro un carcere ci sono persone con cui vai d’accordo e ci sono quelle che invece ti trattano male di continuo. Anche con le guardie bisogna fare sempre attenzione, perché in carcere loro hanno sempre ragione. C’è chi fa il suo lavoro senza cattiveria e chi invece ti provoca apposta fino a quando non cedi, così può farti un rapporto disciplinare. Del mio periodo in carcere un episodio mi ha provocato grande dispiacere e mi ha fatto piangere tanto. Quando hanno chiuso il reparto femminile di Civitavecchia, perché dovevano ristrutturarlo, a me hanno continuato a tenermi lì. Da sola. 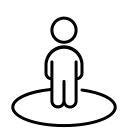 Arrivavano nuovi detenuti in transito e io cucinavo per loro; loro venivano trasferiti a Rebibbia, io no. Allora mi sono fatta forza fino a quando non ho chiesto il primo permesso premio per uscire. Solo allora ho saputo di essere sotto osservazione scientifica. L’osservazione scientifica si può estendere fino a sei mesi a partire dal primo giorno di detenzione, ma io ero in carcere da tre anni e, per di più, lavoravo in cucina con i coltelli tutti i giorni. Ho quindi cercato di spiegare la mia situazione alla magistratura di sorveglianza. Quando il procuratore generale ha dichiarato che il carcere doveva mostrare le relazioni dell’osservazione, il carcere non aveva nulla da mostrare. Non esisteva alcuna osservazione scientifica a mio nome. È stato così che ho ottenuto il primo permesso per poter uscire, mancavano solo pochi mesi alla fine del mio periodo di detenzione”.
Arrivavano nuovi detenuti in transito e io cucinavo per loro; loro venivano trasferiti a Rebibbia, io no. Allora mi sono fatta forza fino a quando non ho chiesto il primo permesso premio per uscire. Solo allora ho saputo di essere sotto osservazione scientifica. L’osservazione scientifica si può estendere fino a sei mesi a partire dal primo giorno di detenzione, ma io ero in carcere da tre anni e, per di più, lavoravo in cucina con i coltelli tutti i giorni. Ho quindi cercato di spiegare la mia situazione alla magistratura di sorveglianza. Quando il procuratore generale ha dichiarato che il carcere doveva mostrare le relazioni dell’osservazione, il carcere non aveva nulla da mostrare. Non esisteva alcuna osservazione scientifica a mio nome. È stato così che ho ottenuto il primo permesso per poter uscire, mancavano solo pochi mesi alla fine del mio periodo di detenzione”.
Il crollo
“Il giorno in cui sono uscita non conoscevo nessuno, avevo tanta paura. Con il primo permesso premio di tre giorni sono stata ospitata in una casa accoglienza dell’associazione VIC, Volontari In Carcere. A loro sono molto grata: mi hanno accolta, dato un posto dove dormire e mangiare, mi hanno trattata bene e, per la prima volta dopo tanto tempo, non mi sono sentita più una carcerata. Intanto all’ufficio immigrazione mi avevano revocato il permesso di soggiorno, così come la carta d’identità, e mi avevano dato sessanta giorni per riuscire a rinnovare i documenti. Per farlo serviva un lavoro. Mi sono data da fare e ho trovato subito un contratto di lavoro come badante per una ragazza disabile. Lo stipendio andava benissimo, 1200 euro al mese. Nel 2019, a pochi mesi dall’uscita dal carcere, ero riuscita a mettere la mia vita, che fino ad allora era stata un disastro, a posto. Ero al settimo cielo. Poi una notte, senza alcun preavviso, è venuta a casa la polizia. “Bum! Bum! Bum!”, ricordo bene gli improvvisi colpi alla porta che fecero balzare dal letto me e mio marito. I poliziotti presero tutti e due ed entrambi finimmo al centro di permanenza per i rimpatri: io a Ponte Galeria, mio marito in quello di Potenza. Volevano mandarci via dall’Italia. 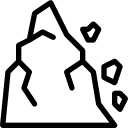 Al centro di espulsione è andata peggio che in carcere. La prospettiva di tornare in Nigeria, dopo quello che avevo passato, era per me impensabile. Perché ero giudicata un pericolo sociale? In carcere avevo dato il massimo, e quando ne ero uscita ero così felice da dirmi: “Karima, ora puoi farlo. Puoi ricostruire la vita che hai distrutto e ricominciare a vivere”. Ma era tutto finito. È stato allora che mi sono detta: “Se mi mandano in Nigeria non so come farò, a questo punto è meglio morire”. Ho provato a suicidarmi nel CPR di Ponte Galeria. Ero arrivata al culmine della sopportazione. Dopo il tentativo di suicidio sono stata per mesi malissimo. La vita per me non aveva più significato, era diventato tutto buio e non riuscivo più a ragionare”.
Al centro di espulsione è andata peggio che in carcere. La prospettiva di tornare in Nigeria, dopo quello che avevo passato, era per me impensabile. Perché ero giudicata un pericolo sociale? In carcere avevo dato il massimo, e quando ne ero uscita ero così felice da dirmi: “Karima, ora puoi farlo. Puoi ricostruire la vita che hai distrutto e ricominciare a vivere”. Ma era tutto finito. È stato allora che mi sono detta: “Se mi mandano in Nigeria non so come farò, a questo punto è meglio morire”. Ho provato a suicidarmi nel CPR di Ponte Galeria. Ero arrivata al culmine della sopportazione. Dopo il tentativo di suicidio sono stata per mesi malissimo. La vita per me non aveva più significato, era diventato tutto buio e non riuscivo più a ragionare”.
Il coraggio di ricominciare
“Quando sono stata meglio sono uscita col certificato del medico che mi curava. Intanto l’avvocato che si occupava della mia vicenda e di quella di mio marito aveva presentato ricorso alla cassazione che, alla fine, ha revocato la misura di sicurezza. Abbiamo fatto di nuovo la richiesta di asilo politico e adesso siamo in attesa di una risposta. Intanto lavoro come babysitter nei fine settimana e faccio la colf durante la settimana. Comincio a sentirmi meglio, io e mio marito viviamo di nuovo insieme. Con il resto della famiglia in Nigeria sono sempre in contatto. Sinceramente non posso condannare l’Italia per quello che mi è successo. 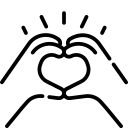 Quando sono arrivata in questo Paese sono stata accolta e mi hanno dato il permesso di soggiorno. Ho distrutto tutto da sola. L’Italia è un Paese accogliente, ma io penso che deve imparare a perdonare. Lo so, ho commesso un errore, adesso l’ho capito e non lo posso giustificare. Ma ciascuno di noi si merita un po’ di felicità nella vita. Anche perché è la vita stessa a cambiarti, e tu non sei più quello di prima, per questo non si può giudicare una persona solo da un errore del passato. Quando qualcuno decide di lasciare il proprio Paese di origine e di attraversare percorsi pericolosissimi lo fa per un motivo forte, come per salvare la propria vita, dimenticare l’inferno e poter ricominciare. Allora vale la pena scappare. Per comportarsi bene è necessario ricordarsi sempre quello che ci ha spinto a lasciare i nostri Paesi, perché spesso dimentichiamo proprio questo. Io non tornerei in Nigeria neanche per una vacanza”.
Quando sono arrivata in questo Paese sono stata accolta e mi hanno dato il permesso di soggiorno. Ho distrutto tutto da sola. L’Italia è un Paese accogliente, ma io penso che deve imparare a perdonare. Lo so, ho commesso un errore, adesso l’ho capito e non lo posso giustificare. Ma ciascuno di noi si merita un po’ di felicità nella vita. Anche perché è la vita stessa a cambiarti, e tu non sei più quello di prima, per questo non si può giudicare una persona solo da un errore del passato. Quando qualcuno decide di lasciare il proprio Paese di origine e di attraversare percorsi pericolosissimi lo fa per un motivo forte, come per salvare la propria vita, dimenticare l’inferno e poter ricominciare. Allora vale la pena scappare. Per comportarsi bene è necessario ricordarsi sempre quello che ci ha spinto a lasciare i nostri Paesi, perché spesso dimentichiamo proprio questo. Io non tornerei in Nigeria neanche per una vacanza”.
La storia di Karima è una delle migliaia di voci che spesso ignoriamo. Eppure il suo coraggio può insegnare molto. Oggi oltre cinquantamila persone sono detenute in Italia, più di un terzo di loro sono stranieri. Il reato più comune continua a essere legato al traffico di stupefacenti.
Vincenzo Lombardo
(8 Dicembre 2021)
Leggi anche:

